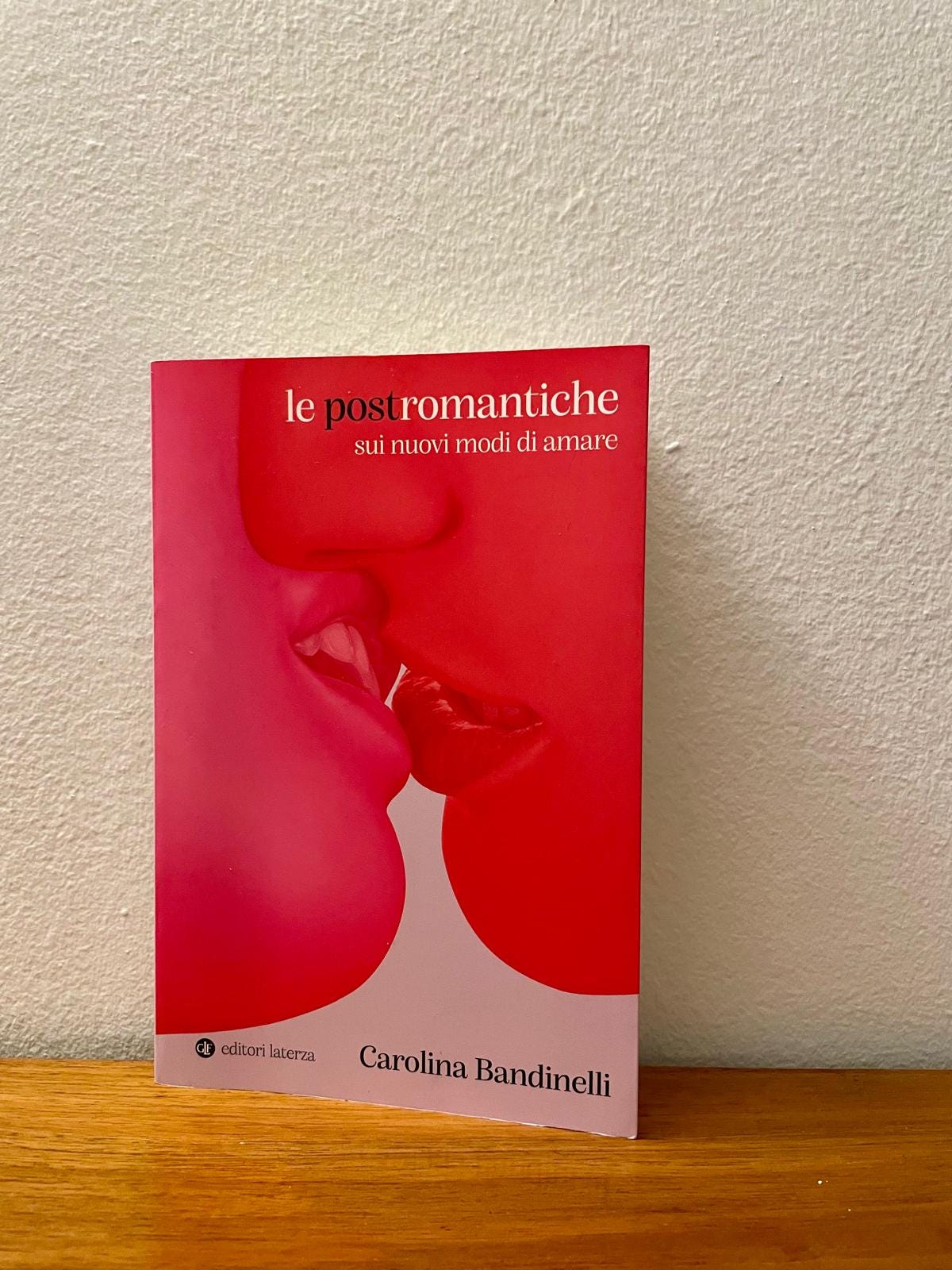Come avrete capito leggendo questa newsletter: ci arrovelliamo spesso sul tema delle relazioni affettive e sulla loro evoluzione nel contemporaneo.
In un mondo che ancora oggi ci vorrebbe tutti in coppia a sposarci e far figli, c’è chi sta sperimentando nuovi modi di amare, mettendo in discussione la posizione prioritaria che diamo all’amore romantico. Perché l’affetto che proviamo verso la nostra famiglia e i nostri amici dovrebbe avere meno valore di quello che proviamo nei confronti del nostro partner? Perché non possiamo rimodulare il nostro tempo e il nostro spazio per accogliere anche altre forme di amore? La monogamia è l’unica strada possibile?
Domande, dubbi e riflessioni che si pone anche Carolina Bandinelli nel suo saggio Le postromantiche, di cui parliamo oggi nella newsletter. Dopo averla conosciuta dal vivo al Festivaletteratura di Mantova (dove lei, Giulia C. e Davide Coppo hanno chiacchierato sulle opere di Gabriella Parca), abbiamo proposto a Carolina di confrontarci su questi temi.
Anche perché negli ultimi mesi è uscito in libreria il suo primo romanzo, La più brava, in cui si affrontano molte delle questioni essenziali per la nostra generazione: diventare adulti, affrontare i propri desideri e le proprie paure.
Buona lettura!
Le postromantiche di Carolina Bandinelli (Laterza, 2024)
Intervista a Carolina Bandinelli
Da tempo ti occupi di amore e relazioni nelle tue ricerche accademiche, ben prima che nascesse Le postromantiche. Come mai?
In fondo penso che nasca tutto dal mio desiderio di rispondere a una domanda che mi porto dentro dalla prima infanzia, cioè: come si fa a essere amate? Forse la prima domanda di cui ho memoria. Quando ero piccola volevo essere amata dagli animali, dai pappagallini, dai cani. Volevo, come Cenerentola, avere una comunità di supporto di riferimento ed essere l'altra significativa per loro. E poi ovviamente c'è stato il rapporto con i genitori: l'amore dei genitori, e poi l’amore in generale, è uno degli strumenti attraverso cui si costruisce l'identità di genere e quindi si socializza, nel mio caso, come ragazze e come donne.
La nostra generazione parla molto d’amore e di relazioni; ci sono romanzi, libri di autofiction, serie tv, film, podcast che trattano l’argomento. Eppure Le postromantiche fa qualcosa che pochi di questi prodotti culturali fanno e cioè trattare l’amore come un fenomeno sociologico e culturale.
Si soffre tanto per amore, no? Ci si sente tanto sbagliati o sbagliate per amore. Quando ho incontrato la tematizzazione dell'amore dal punto di vista della sociologia culturale e degli studi culturali, è stato un momento che ha cambiato il mio sguardo e anche il modo di relazionarmi a me stessa, perché ho capito che l'amore è anche un fenomeno culturale e che quindi il modo in cui amiamo, le difficoltà, quello che non funziona nell'amore non è soltanto una questione individuale di non essere abbastanza amabili e desiderabili, abbastanza brave o bravi, ma è anche il risultato degli imperativi culturali che spesso sono irraggiungibili.
Già a partire dal titolo, Le postromantiche si rivolge soprattutto alle donne e ha anche un carattere generazionale: parla alle donne millennial e in particolare a quelle eterosessuali (pur mettendo in discussione anche l’eterosessualità). Al di là dell’esperienza autobiografica, perché hai deciso di assumere questa specifica prospettiva?
La questione di genere, per quanto non sia l'unica questione, è una questione importante perché è un fatto storico, culturale: per molto tempo alle donne è stata data in gestione la sfera affettiva, quella della riproduzione e quella della cura. L'amore romantico è stato escluso fino a pochi decenni fa da questa sfera, per molto tempo è stato solo una fantasia, un orizzonte utopico. Poi con la rivoluzione sessuale degli anni Settanta, per fortuna, l'amore romantico è stato reintegrato nella sfera di quello che si può effettivamente vivere, perché le relazioni sono state svincolate dalle norme religiose tradizionali. Quindi non è che devi soltanto sposarti, occuparti della casa e della crescita dei figli, puoi finalmente innamorarti e vivere la vita che prima era appannaggio esclusivo delle eroine romantiche. È stato quello il momento in cui l'amore romantico è diventato parte di quello che ci si aspetta da una buona vita. Poi con lo sviluppo dell'industria mediale e culturale di massa è diventato parte significativa della storia di tutte noi. In questo hanno avuto un ruolo fondamentale i magazine al femminile e le commedie romantiche. La trama romantica oggi è un prodotto di consumo e come tutti i prodotti di consumo nel capitalismo ha un doppio ruolo: da una parte si presenta come un bene accessibile, dall'altro lato ti dice che se non lo consumi (perché non hai abbastanza soldi, o non hai abbastanza capitale erotico) è un problema tuo. Noi millennial siamo cresciute in un contesto in cui l'amore era accessibile, ma è diventato quasi un imperativo, una prescrizione: ci si deve innamorare; se non ti innamori, se non trovi l'uomo giusto, se non hai esperienze sessuali travolgenti, se qualcuno non ti dedica una canzone, è un problema. Negli anni Ottanta e Novanta per vivere l’amore romantico abbiamo iniziato a chiederci: come faccio a essere abbastanza per ottenerlo? Questo lo si vede anche nella narrativa sul sesso: in pochi anni si è passati dal sesso come tabù inaccessibile agli articoli di Cosmopolitan su come fare un pompino fatto bene. Si è passati da un atteggiamento moraleggiante, censorio, a una prescrittività professionalizzante. Secondo me il chiedersi effettivamente come soddisfare questo imperativo ha fatto parte della socializzazione di genere. Sicuramente anche gli uomini eterosessuali parlano d'amore però per le donne è un argomento di condivisione.
Insomma, l’amore romantico è stato un dispositivo di segregazione e di soggiogamento del femminile. Anche oggi sembra quantomeno fonte di una grande frustrazione.
Certo, adesso siamo frustrate perché effettivamente ci siamo accorte che non funziona; non funzionava per la mia nonna che si è sposata un solo uomo, si è presa un monte di corna, si è vista tradire con la parrucchiera e ha dovuto vendere la sua casa per ripagare i debiti delle carte del marito; non ha funzionato più di tanto nemmeno per mia mamma, che ha vissuto un divorzio e si è sobbarcata la cura dei figli, che ha rinunciato alla carriera e che una volta ha dovuto abortire illegalmente; e anche per la mia generazione ha funzionato fino a un certo punto. Sentirsi, in quanto donne, le uniche manager dell'amore, dell'affettività, forse è un compito che non vogliamo, che iniziamo a vedere come un lavoro, più che come un'espressione libera della nostra natura di eroine romantiche con le ovaie. Secondo me per le famose nuove generazioni e forse anche per una parte di noi millennial che viviamo questa scissione, l'amore romantico va superato. Queste sono le postromantiche, quelle che sono ancora romantiche però credono che questa visione andrebbe superata. Quando parlo con le mie studentesse, o mi trovo ad avere a che fare con ragazze e ragazzi più giovani di me di 10-20 anni, mi rendo conto che nei loro discorsi l'amore non ha la stessa posizione prominente. C’è una rivalutazione dell'amicizia e c'è il rifiuto dell’idea che le relazioni romantiche (dove per romantiche si intende anche quelle sessuali) siano gerarchicamente superiori alle altre. E c'è, secondo me, la ricerca anche di nuove forme e configurazioni, in cui il vissero felici e contenti non ha più la forma di una coppia che si sposa.
E questo non credi che derivi anche da quella che nel libro definisci etica preventiva, ovvero quell’atteggiamento per cui rifuggiamo l’amore perché tendiamo a rifuggire il trauma? Nel libro fai notare per esempio quanto il modo in cui parliamo oggi d’amore attinga ai termini della psicologia clinica…
Sì, finora abbiamo parlato del processo di svelamento degli aspetti ideologici e problematici del mito dell'amore romantico, poi ovviamente c'è la domanda successiva: e quindi come si costruisce un nuovo amore? Che cosa chiediamo all'amore nuovo? Il rischio è esattamente questo: questa nuova filosofia o distopia di un amore che non fa male. Ora riconosciamo i dolori inflitti da una mitologia del romantico in ultima analisi irraggiungibile e conosciamo la fatica che è toccata soprattutto alle donne nel cercare di tenere insieme i pezzi. Non tutti i traumi affiorano nel momento in cui li subisci, può essere che a distanza di tempo tu ti accorga che le esperienze che hai vissuto sono state traumatiche, anche se al tempo le consideravi normali. Secondo me adesso siamo a un punto in cui stiamo facendo i conti con tutta una serie di cose che ci sembravano normali, con dei dolori che ci sembravano poetici e invece non lo erano affatto. È un momento di grossa crisi, che si trasforma in un'attitudine preventiva. Il postromantico che non è ancora andato oltre, che non ha ancora trovato un paradigma alternativo, è segnato da questa attitudine che cerca di evitare il trauma, di individuarne i semi fin dalle primissime interazioni (pensiamo alle famose red flag). Possiamo parlare di ipocondria delle relazioni, che si arma di un apparato pseudo-diagnostico, ovvero la volgarizzazione della psicologia clinica. Cerchiamo una diagnosi perché protegge, ma la diagnosi mette un cartellino e crea distanza.
Il tuo Le postromantiche, ma anche molte altre analisi recenti, non faticano a identificare il nemico di questa impasse amorosa e relazionale nel capitalismo. Insomma, la domanda da un milione di dollari: è più facile immaginare un nuovo amore o la fine del capitalismo?
Quando Mark Fisher parlava di capitalismo e realismo e diceva che è più facile immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo, non stava dicendo che effettivamente il capitalismo non finirà mai e finirà prima il mondo, ma stava identificando uno dei modi in cui il capitalismo lavora nel costituire le possibilità di immaginazione del soggetto. Il soggetto capitalista è un soggetto che non riesce a immaginare altro da quello che vive, ma questo non significa che non ci sia altro. Lo sguardo occidentale del soggetto moderno crede alla modernità, alla tecnica e al fatto che questo sia il migliore dei mondi possibili. Questa però è una lente ideologica: ci sono scuole di pensiero, intellettuali, artisti che vivono in contesti altri, fuori dal centro del capitalismo. Non significa andare soltanto fuori dall'Europa e dall'America, significa anche andare fuori dalle città globali, dai centri finanziari, dagli studi di vita e di consumo della classe media; ci sono tante aree periferiche, considerate periferiche, a cui forse occorre guardare con uno sguardo diverso. Forse nelle periferie dell'impero (per usare un termine anacronistico però probabilmente ancora capace di comunicare quello che stiamo dicendo) invece di esserci il passato c'è in qualche misura anche il futuro. E poi non bisogna mai dimenticarsi che il potere è una relazione: è chiaro che noi siamo soggetti al potere, però è chiaro anche che lo negoziamo sempre. Esistono tattiche, esistono strategie, esistono controculture e modi controculturali per resistere.
Carolina Bandinelli è Associate Professor in Media and Creative Industries all’Università di Warwick. Da più di dieci anni contribuisce al dibattito culturale, in Italia e all’estero, con interventi su lavoro creativo, desiderio e media digitali. La sua ricerca è apparsa su testate internazionali tra cui Bbc, New York Times, El País. Nel 2024 ha pubblicato Le postromantiche: sui nuovi modi di amare (Laterza), un saggio personale sulla cultura dell’amore e del sesso. La più brava (Nutrimenti, 2024) è il suo primo romanzo.
Cose belle che abbiamo letto in giro
Questa settimana non si può non parlare delle elezioni americane. Partiamo con una piccola buona notizia: in dieci Stati si è votato anche per inserire in Costituzione la possibilità di interrompere legalmente la propria gravidanza. Il referendum è passato in sette Stati su dieci. È ancora presto per i dati complessivi di queste elezioni, ma c’è chi si chiede se una donna riuscirà mai a essere Presidente degli Stati Uniti. E quanto la misoginia abbia avuto una parte in questo risultato.
Cosa si sa della donna iraniana (sembra che il suo nome sia Ahoo Daryaei, ma non c’è ancora certezza) arrestata dopo essersi svestita in pubblico.
In Inghilterra e Galles è diventato illegale per gli attivisti anti aborto manifestare a meno di 150 metri da un ospedale o una clinica dove si praticano interruzioni di gravidanza con l’intenzione di influenzare la decisione delle donne.
Ci sono le prime condanne per l’omicidio di Marielle Franco, la consigliera comunale di Rio de Janeiro uccisa nel 2018.
L’attrice di Sex Education, Gillian Anderson, ha pubblicato un libro in cui raccoglie oltre 800 fantasie sessuali che hanno voluto condividere con lei donne di tutto il mondo.
Tra i libri che ci sono arrivati negli ultimi giorni c’è anche È una donna che vi parla, stasera di Alba de Céspedes sulle vicende vissute dalla scrittrice nell’Italia del post 8 settembre 1943. E prosegue la pubblicazione delle opere di Susan Sontag da parte di Nottetempo.
Selfie, o il diritto al narcisismo: una riflessione sulla propria immagine.
Nella newsletter Singolare, femminile si parla di Anora, il film di Sean Baker che arriva il 7 novembre al cinema.
Licia Lanera ha messo in scena per la prima volta Altri libertini di Pier Vittorio Tondelli.
Vi ricordiamo anche che il 20 novembre ci sarà il prossimo incontro, ultimo dell’anno, con il bookclub di Senza rossetto da Verso a Milano. Stiamo leggendo Musica da camera singola di Amy Key. Sul tema ci è arrivata anche la segnalazione di un podcast, Il Cuore scoperto, che a partire da un progetto in lingua francese ora tradotto in italiano, riflette su nuove forme di affettività e dello stare insieme, andando oltre alla concezione classica dell’amore romantico.
A presto,
Vuoi darci una mano?
Senza rossetto è un progetto a budget zero. Tutto il lavoro dietro al nostro podcast e a questa newsletter è volontario e non retribuito, ma è un lavoro che richiede molte forze e anche qualche soldo. Se vuoi aiutarci a sostenere le spese di produzione, incoraggiarci o anche solo offrirci una caffè puoi farlo attraverso PayPal usando la mail info@senzarossettopodcast.it, oppure puoi impostare una donazione ricorrente sul nostro profilo Patreon. Ogni aiuto sarà per noi prezioso, quindi grazie!
Seguici!
Il nostro sito è senzarossettopodcast.it, ma ci trovi anche su Facebook, Instagram e Twitter.
Se invece hai idee da proporci, suggerimenti da darci, segnalazioni da fare (anche queste, per noi, sono importanti) scrivici all'indirizzo info@senzarossettopodcast.it. E se questa newsletter ti è piaciuta, girala ai tuoi amici!